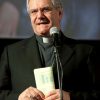Le prime due parti sono state pubblicate sui due numeri precedenti. Riguardavano i ricordi familiari, gli anni di formazione, l’ordinazione sacerdotale, le prime esperienze pastorali, le figure dei vescovi Morstabilini e Foresti.
GUSTI E PREFERENZE
Lei ha studiato musica, dunque. Quale compositore preferisce? Quali opere musicali predilige?
La musica mi piace tutta. Con il passare del tempo sono cambiati anche i miei gusti. Più che un autore, dovrei dire che di ogni autore prediligo qualcosa. Ho fatto molta musica barocca. Ma ho fatto anche molta musica moderna e sperimentale. Negli ultimi tempi sono tornato a gustare intensamente il gregoriano. Mi piace anche il jazz. Se dovessi dire quale è il genere che preferisco, la forma musicale che ho praticato e mi ha appassionato e mi appassiona di più è la musica da camera. Non è un caso che avevamo messo insieme anche un quartetto d’archi, proprio per suonare quella musica che prediligevamo.
Quale è il suo atteggiamento verso la musica leggera?
Verso la musica leggera ho l’atteggiamento che credo sia quello dominante nella maggioranza degli italiani. Quando mi si parla di musica leggera penso ad alcuni grandi cantanti: Celentano, Modugno, Mina, Milva… Faccio un po’ fatica a usare il termine “musica leggera”. Esiste una musica banale, commerciale; ma esistono canzoni che, come hanno segnato la nostra vita collettiva, così hanno segnato la mia vita personale. Penso ai vari generi: il pop, il folk, il rock, il jazz. Penso ai grandi complessi della mia giovinezza: i Beatles, i Rolling Stones, i Pink Floyd… Penso anche ai cantautori che mi hanno accompagnato: De André, Guccini, Gaber, Jannacci…
Possiamo chiederle anche un suo parere di massima, da vescovo musicista, sulla musica liturgica? Ci sono tra i brani attualmente usati, alcuni che le piacciono particolarmente e che ritiene possano passare alla storia della musica liturgica?
Tocchiamo un tasto delicato. Bisogna riconoscere che, in questi decenni, non si è affermato uno stile, un modo riconoscibile di fare musica sacra. Ritengo che della produzione attuale non resterà nulla nella storia della musica. Sono soddisfatto dell’impostazione diocesana del problema della musica sacra, ma esistono molte, troppe diversità da una parrocchia all’altra. Abbiamo la fortuna di poter usare ottimi organi in molte delle nostre comunità locali: l’organo, in effetti, resta lo strumento principe della musica sacra in Occidente. Si incontrano bravi organisti e ottime cappelle musicali. Sono anche convinto che è possibile utilizzare musica di tipo ritmico, diversa da quella tradizionale. Ma si deve sempre valutare in modo serio lo stile della musica e del canto e, in particolare, la sua valenza liturgica. Le chitarre si possono usare, ma non bastano un paio di chitarre per fare buona musica sacra. Lo stile del canto sacro è dunque ampiamente da ripensare e resta da curare una seria educazione al buon uso della musica, per i sacerdoti e per i laici, soprattutto quelli impegnati nella liturgia. Con un punto fermo irrinunciabile: l’assemblea deve mantenere un ruolo determinante. In nessun caso si deve accettare che sia messa da parte per far posto a qualcuno che canta al suo posto.
L’abbiamo sentita qualche volta citare Manzoni. Quali sono i suoi classici preferiti in narrativa? E in poesia? Ha qualche autore preferito anche fra i moderni e i contemporanei?
Mi piace molto leggere: mi porto appresso anche oggi le buone abitudini che ho appreso nella mia infanzia. Mi piace molto la narrativa e mi piace la saggistica. Certo, Manzoni resta in cima alle mie preferenze. Ma non ho dimenticato l’epica di Omero che continua ad affascinarmi. Come mi affascinano i tragici greci. E poi: Fedor Dostoevksij, Bertolt Brecht, Joseph Roth, Chaim Potok… Tra i contemporanei Erri De Luca e Alessandro Baricco. Tra i saggisti prediligo Claudio Magris. Ma, su tutti, una specie di breviario quotidiano sono per me Dino Buzzati e Martin Buber. Siccome mi sono sempre piaciute le fiabe, continua a godere molte delle mie preferenze Gianni Rodari. Ultimamente ho letto diversi romanzi di Arto Paasilinna, straordinario scrittore finlandese, che si fa leggere con grande piacevolezza, ma che offre anche spunti esistenziali decisamente stimolanti.
LA CHIESA DI BERGAMO E LO STILE DEL GOVERNO ECCLESIALE
Non le è mai capitato di dirsi: Cosa ho fatto ad accettare di fare il vescovo a Bergamo?
Avverto sempre più intensamente, con il passare del tempo, il senso dei miei limiti e una acuta sensazione di inadeguatezza. Ho sempre fatto presente le mie ragioni, ma poi, se i superiori non tornavano sulla loro richiesta, ho sempre finito per accettare. Non sono mai riuscito a dire di no e ai superiori e meno che meno al Papa.
Non l’abbiamo ancora visto arrabbiato. Ma proprio non le è mai capitato di mandare a quel paese qualcuno? E questo straordinario self control le è costato molto, le costa molto? Fa parte del suo carattere o è frutto di un’ascesi personale?
A volte mi arrabbio, raramente. Ma se devo essere sincero, se non mi arrabbio, ci riesco non per ascesi – forse mi aiuta un po’ il carattere – ma per orgoglio. Quando mi vedo arrabbiato, infatti, appaio a me stesso molto ridicolo. Quando, invece, sono interiormente tranquillo, riesco anche a essere forte, a impormi e, quando necessario, a imporre in maniera convincente la mia volontà.
Tutti apprezzano la sua amabilità e la sua gentilezza. Qualcuno, però dice che questo crea qualche problema quando deve affrontare le persone e soprattutto quando deve decidere. È vero? Che cosa prova quando deve prendere una decisione pesante, soprattutto quando è coinvolta una persona?
Dire a una persona, a un prete soprattutto, qualcosa di sgradevole non è facile. Se debbo farlo, non mi sottraggo. Tenendo comunque presente che oggi siamo tutti piuttosto fragili e facili a invocare una forza per gli altri che si fatica ad accettare per sé. Per quanto riguarda le decisioni da prendere, devo dire che non sono quello che si chiama un decisionista. Preferisco, l’ho già detto sopra, un lavoro insieme. Devo riconoscere che questo potrebbe anche essere un alibi. Ma amo tenere ben presente la complessità delle situazioni e dei problemi che devo affrontare. Cerco di avere coraggio ma cerco anche di coniugare il coraggio con il senso del dovere e con l’assunzione di responsabilità che mi porta a farmi carico delle situazioni che mi trovo davanti.
Quali sono i sentimenti che le passano nell’animo quando un prete le dice che intende lasciare il sacerdozio?
Ho sempre pensato di aver sofferto poco nella mia vita. Da quando sono vescovo le prove sono aumentate e le sofferenze anche. Quando un prete mi comunica di voler “lasciare”, quello per me è uno dei momenti di più acuta sofferenza. Negli ultimi tempi, quando mi capita di passare attraverso questa esperienza, mi sento smarrito: mi casca addosso uno di quegli eventi che “non dovrebbero” capitare mai. Poi il senso dell’accoglienza prevale e mi sforzo di andare incontro alle esigenze di chi mi sta di fronte, senza pressioni, senza secondi fini e senza la pretesa che l’attenzione data da me possa far tornare sulle decisioni prese. Anche qui mi sforzo comunque e sempre di rispettare. Ma credo di non essere l’unico. Mi sembra, infatti, che la nostra diocesi non dimentichi coloro che hanno fatto queste scelte dolorose. Dolorose per chi resta e, credo, anche per chi lascia.
CHIESA, PRETI, LAICI
Lei ritiene che il Consiglio Pastorale diocesano e il Consiglio Presbiterale siano organismi che incidono effettivamente sulla vita della Chiesa di Bergamo? Oppure rischiano di essere organismi prevalentemente ornamentali?
Il rischio esiste. Resto convinto che una chiesa “comunione” deve tradursi in forme concrete di partecipazione. Dopo il mio arrivo a Bergamo mi sono sforzato di individuare anche forme nuove per assicurare quella partecipazione. Di forme si può discutere e le forme usate si possono cambiare. Ma che si debba favorire quella partecipazione deve essere al di là di ogni dubbio, perché ne va della natura stessa della Chiesa.
La Chiesa di Bergamo spesso è definita troppo clericale. Che cosa pensa di questa accusa? I preti davvero contano ancora troppo?
Non so se i preti contino troppo. Dico soltanto che deve crescere la coscienza, la consapevolezza, l’esercizio della laicità impregnata di Vangelo, da parte di coloro che vivono quella vocazione. Questo può portare a rivedere stili e modi di comportamento da parte dei sacerdoti e anche i modi e gli stili di presenza dei laici nella società bergamasca.
È appena morto don Sergio Colombo. Che cosa può dire di lui? Che opinione se ne era fatto?
Quando sono arrivato a Bergamo, già conoscevo di fama don Sergio, come teologo e pastoralista già ben noto oltre i confini della nostra diocesi. Lui con grande generosità si è messo in rapporto con me e mi ha offerto la sua collaborazione. Ho sempre ammirato la sua mitezza unita alla straordinaria forza della sue convinzioni e, cosa del tutto originale in lui, la felice sintesi fra il teologo e il parroco. E’ questo un elemento da custodire in tutti i modi possibili e prego il Signore che la sua mancanza non significhi disorientamento e carenza di progettazione pastorale nella nostra diocesi.
Lei vede una qualche forma di risposta all’eventuale clericalismo ecclesiastico nei nuovi movimenti ecclesiali, dai Focolarini al Rinnovamento nello Spirito, da Comunione e Liberazione ai Neocatecumenali e gli altri ancora? Qualcosa potrebbe venire anche dall’Azione Cattolica?
Ritengo, da tutta l’esperienza che ho fatto, che i movimenti siano un dono di Dio alla Chiesa di questo tempo. Certamente si sono attraversate delle fasi anche problematiche, alcune con incomprensioni che, in qualche caso, non sono state ancora completamente superate. Ritengo che i movimenti sono una grande chance nella quale si esprime quella che si potrebbe chiamare la soggettività laicale, il genio proprio del laico. Mi sembra che, nei movimenti, il contributo che viene dalla soggettività laicale sia molto connotato dai carismi dei fondatori, che vengono poi riconosciuti e vissuti da coloro che aderiscono al movimento.
Nello stesso tempo è chiaro che ogni movimento si caratterizza per alcune sottolineature carismatiche che lo rendono ciò che è e contribuiscono all’edificazione della Chiesa la quale resta sempre, evidentemente, più grande di ogni singolo movimento e di ogni singolo gruppo.
Provi ad esprimerci un sogno ad occhi aperti: una bella parrocchia bergamasca come lei la vorrebbe tra venti o trent’anni.
Sogno una parrocchia che costruisce un mondo significativo di relazioni, che sia fermento vivo sul territorio, anche per quella parte di territorio che non si riconosce immediatamente dentro i confini della comunità credente. Può essere, infatti, che meno persone partecipino alla vita della comunità parrocchiale ma essa dovrebbe rappresentare comunque un punto di riferimento importante per tutti. Credo, non solo sull’onda della provocazione di Papa Francesco, ma anche per mia convinzione e sensibilità, che la parrocchia del futuro dovrà essere estroversa, sempre meno preoccupata di sé e sempre più preoccupata della missione che Cristo le ha affidato, attenta ai tanti mutamenti che avvengono a velocità spesso sorprendente. Nel sogno ci stanno anche le giovani generazioni: le immagino sempre più protagoniste.
IL RAPPORTO FRA CHIESA E SOCIETÀ
Alcune settimane fa c’è stato l’assorbimento del Credito Bergamasco che è legato nella storia a filo doppio con la chiesa locale. Ci sembra utile partire da questo dato di cronaca per chiederle come vede il rapporto tra i credenti e questa società in cui ci sono elementi interessanti della storia del movimento cattolico ma anche elementi di estraneità e lontananza da questa tradizione.
Credo che la Chiesa di Bergamo non solo abbia perseguito una pastorale attenta ai segni dei tempi ma si sia anche dotata di volta in volta di strumenti molto concreti, com’è proprio del nostro carattere. Credo che i valori che hanno ispirato queste scelte pastorali siano la vicinanza alla gente e alle condizioni di vita delle persone e quindi la cultura. Chiaro che le vicende possono anche portare a veder scomparire alcuni degli strumenti che in passato sono stati di grande rilevanza. Per un verso è la storia che si rinnova, per un altro si deve fare in modo che non vada persa l’anima e l’intelligenza che avevano saputo creare quegli strumenti. Per cui oggi bisogna interrogarsi su quali sono e la forma e gli strumenti necessari per perseguire quella forma. Non è un passaggio semplice. La presenza della Chiesa, nella società bergamasca, deve essere percepita sempre meno come una presenza di potere, e sempre più come presenza che fermenta e che libera energie, che è capace di comunicare ancora un intenso senso di speranza.
Si stanno avvicinando le elezioni amministrative, lei come vescovo che cosa auspica?
Ci sono due aspetti che mi piacerebbe porre come punto di partenza della riflessione. Primo. E’ necessario che le singole persone, i gruppi, le comunità mettano in evidenza le condizioni necessarie per perseguire il bene comune e quindi per costruire una comunità in cui tutti possano ritrovarsi. Stiamo scontando una drammatica contraddizione: da un lato siamo presi da un individualismo dal quale non riusciamo a liberarci, dall’altra vorremmo costruire una società nella quale abitare con sicurezza. È una contraddizione che si riflette anche nella politica. La ricerca di alcune condizioni fondamentali è il punto di incontro necessario, altrimenti rischiamo di involverci in mille riflessioni che ci allontanano ancora di più dalle speranze che invece dovremmo coltivare. Secondo. Abbiamo vissuto tempi in cui il benessere e la sicurezza sociale si erano fortemente consolidati. Oggi è la crisi, ma viviamo ancora di quel retaggio e coltiviamo la speranza di poter recuperare quella condizione. Non abbiamo ancora avuto il coraggio di imbastire un discorso che prenda atto del profondo cambiamento che stiamo vivendo.
Nel pensare al cambiamento a che cosa si riferisce? Esistono ambiti particolari nei quali appare di più il cambiamento e la necessità di una cultura del cambiamento?
Credo che le prospettive aperte dall’Expo 2015, quelle legate alle grandi infrastrutture del nostro territorio, al mondo del lavoro, siano quelle che ci obbligano a porre la questione se vogliamo davvero cambiare e, nel caso, quale cambiamento sociale e culturale vogliamo realizzare. Non si ha il coraggio di mettere in discussione l’individualismo che segna tutti i nostri rapporti. Ma se continuiamo così come potremo creare delle relazioni costruttive? E quando parlo di cambiamento, non parlo di cambio di amministrazione. I cambiamenti sono molto profondi: cambiano i tempi, cambiano le cose, tutto è in movimento. Di fronte a questo Bergamo che fa? Questa città e questa provincia hanno delle enormi potenzialità. Io la amo molto e mi piace starci. Ma penso sia necessaria un po’ di passione per affrontare coraggiosamente tutti questi problemi. E mi piacerebbe che si cominciasse, evangelicamente, da chi di problemi ne ha più degli altri.
A questo proposito, ha in mente qualche situazione particolare?
Mi piace molto l’immagine che qualcuno nel mondo del volontariato ha usato: andiamo a fare la ronda dei poveri. Bellissimo: questi che vanno in giro di notte, vanno a cercare i barboni, i rifiutati, i marginali… Costruiscono legami dove non ce ne sono. E’ quello che dovremmo fare tutti perché non si può chiedere di essere più sicuri se continuiamo a crogiuolarci le nostre solitudini. Penso anche al tema della violenza sulle donne: tema significativo anche in rapporto alla relazione uomo-donna. Se l’uomo non ha altri argomenti e si mette a picchiare, vuol dire che è segnato da una preoccupante forma di debolezza. Ma allora: quale è la qualità dei rapporti tra l’uomo e la donna e quale è la capacità di instaurare autentiche relazioni? Sono convinto che, sotto il profilo della cosiddetta elaborazione del vissuto, le donne sono più avanti degli uomini e questi, spesso, si trovano in difficoltà, talvolta anche quando sono culturalmente preparati. Un’altra questione cruciale mi viene in mente: i bergamaschi che hanno fatto del lavoro un loro punto di forza, come mai sono così presi dal gioco e dalle scommesse? Non è una questione da poco. Il lavoro in crisi ha fatto nascere anche una crisi della cultura del lavoro. Anche il tema della scuola è decisivo. La società deve preparare il suo futuro e guai a noi se le urgenze del presente ci fanno dimenticare il nostro futuro…
3. Fine